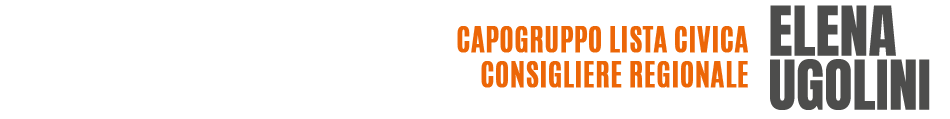Questa mattina, nella sala conferenze del MamBo, ho partecipato al convegno “Verso il nuovo piano di tutela delle acque attraverso un nuovo modello di gestione”. Erano presenti anche il Presidente de Pascale, Annalisa Sassi, presidente di Confindustria Emilia-Romagna, Tonino Bernabé, presidente di Romagna Acque, Gianpaolo Bottacin, presidente dell’Agenzia interregionale per il fiume Po, e Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione nazionale dei Consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue.
Nel corso dell’evento sono stati presentati due studi: il primo su di un nuovo piano di tutela delle acque e un secondo sui nuovi modelli di governance necessari per far fronte ad un sistema evidentemente inadeguato. (Basti pensare che l’ultimo piano di tutela delle acque in Emilia-Romagna è stato realizzato nel 2005, mentre quello precedente risaliva al ’77). Quelli presentati questa mattina sono due studi approfonditi che aiutano a costruire una visione complessiva di che cosa possa significare un governo delle risorse idriche del nostro territorio per evitare di oscillare tra alluvioni e siccità, per garantire la chiarezza e la trasparenza di ruoli e funzioni dei diversi Enti, per accorciare “la catena di comando”, la più lunga fra quelle esistenti nelle regioni italiane. Per questi motivi ho fatto una richiesta di audizione, in Commissione III territorio ambiente e mobilità, degli esperti e dei vertici di Confindustria Emilia-Romagna che hanno curato i due studi . L’obiettivo è dare un contributo alla costruzione di quanto dice il documento di economia e finanza regionale 2025-2027 che prevede:
-l’approvazione di una legge regionale in materia di organizzazione delle funzioni di sicurezza territoriale e difesa del suolo;
-l’elaborazione della carta regionale del dissesto idrogeologico e idraulico in ambito collinare montano;
-l’aggiornamento dei piani di assetto idrogeologico.
Nella nostra regione è necessaria una visione di insieme che realizzi un vero cambio di paradigma, non un “rattoppo” di quello che non ha funzionato. Questo è quello che si aspettano i cittadini emiliano romagnoli. Prendere sul serio questi contributi può essere il segno di un primo passo per farlo.
Già negli anni ‘70 erano già state progettate venti dighe, ma l’ultima realizzata fu quella di Ridracoli nel lontano 1982. Se fosse stata progettata anche quella di Vetto, avremmo evitato problemi ingenti al territorio e alle persone. Basti ricordare il disastro avvenuto a Lentigione.
Ogni anno gli emiliano romagnoli consumano due miliardi di metri cubi all’anno mentre ne finiscono dispersi in mare altri 6 miliardi, oltre all’ampio spreco idrico dovuto a tubature ormai inadeguate.
Oltre a ciò, dopo la legge regionale del 1999 che ha recepito il trasferimento delle competenze sull’acqua stabilite dalla legge Bassanini, la Regione ha allungato oltremodo la catena di gestione. Quella dei fiumi è passata all’agenzia della sicurezza del suolo e Protezione civile, sono diventante necessarie le autorizzazioni dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale e ben otto sono Consorzi di bonifica oltre agli enti locali chiamati ad intervenire in particolari situazioni. In caso di aree protette, poi, diventa necessario anche il nulla osta dei vertici delle zone interessate. Snellire questa catena di comando, la più lunga esistente fra le regioni italiane, può e deve essere una priorità, ad esempio prevedendo un unico referente per ogni Bacino idrografico principale in modo da portare a compimento una governance sulle acque a catena corta.
La sfida per il prossimo futuro è realizzare opere necessarie per mettere in sicurezza l’ambiente salvaguardandolo e valorizzando la risorsa idrica. Occorre mettere al centro delle politiche territoriali le persone e le loro competenze. Dobbiamo favorire un approccio sussidiario basato sulla competenza professionale oltre che sulla presenza degli agricoltori e dei soggetti economici che insistono sul territorio. Un approccio che premi la prevenzione e superi il sistema basato esclusivamente sui vincoli della pianificazione, sulle paralisi derivanti da una visione ambientalista ideologica, sul volontariato nella gestione delle emergenze e sull’assistenzialismo successivo agli eventi catastrofici.